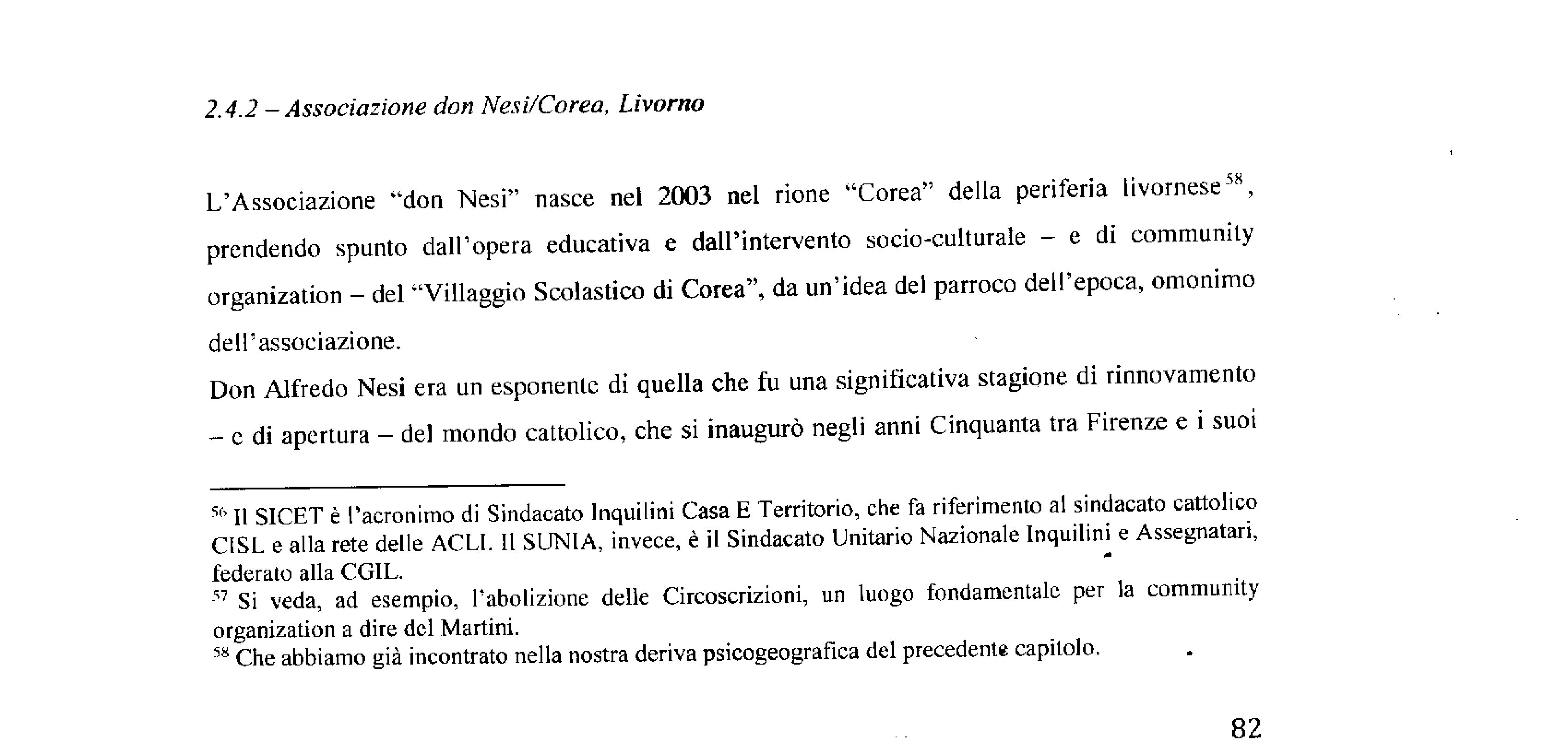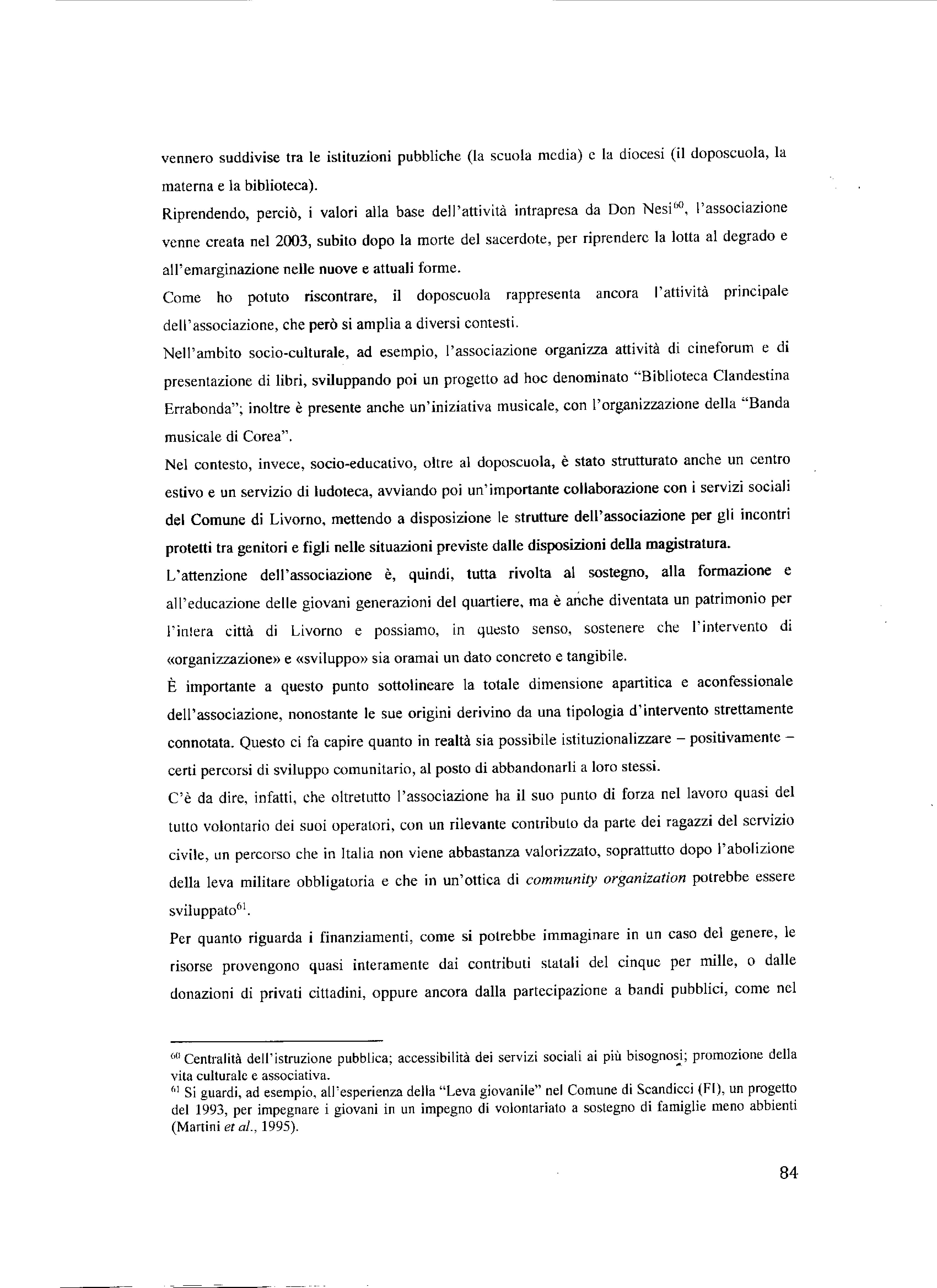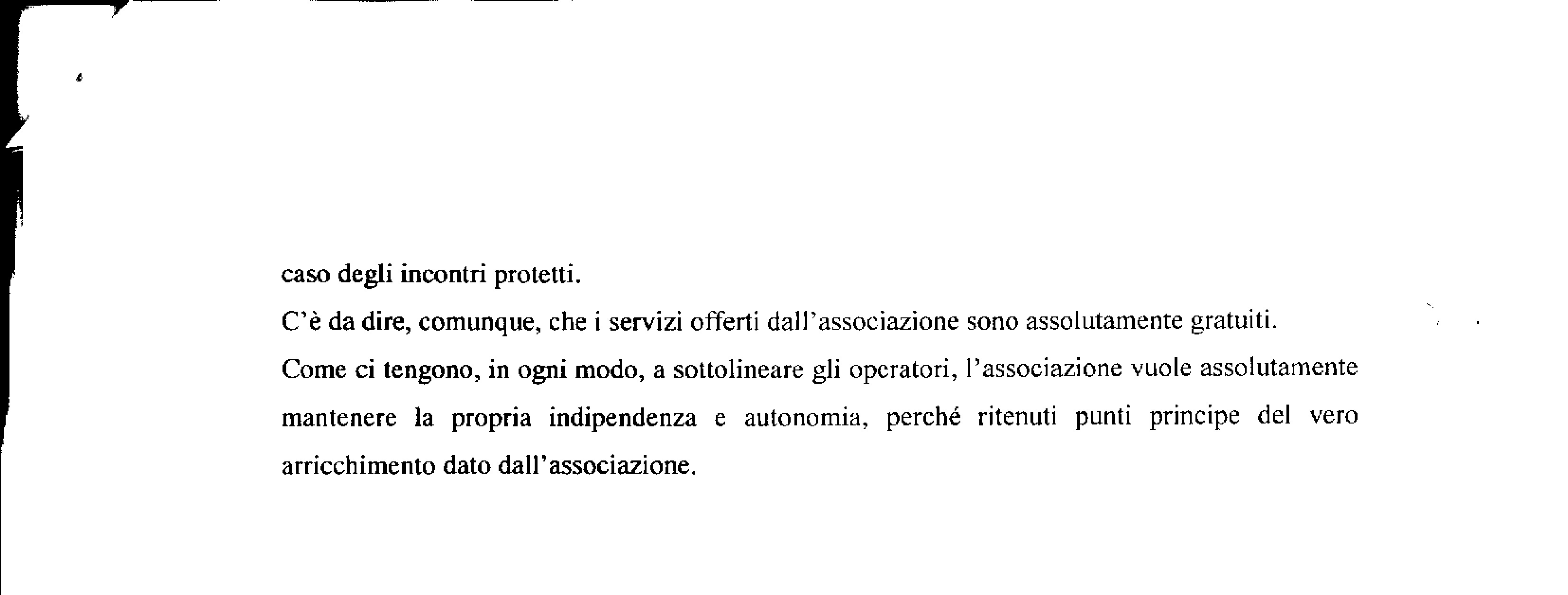TESI “COMUNITA’ VS. MARGINALITA'” di Simone di Renzo (Paragrafo, Report, Slides e Tesi)
Pubblichiamo il paragrafo dedicato all’Associazione don Nesi/Corea e pubblicato all’interno della Tesi di laurea in Sociologia Urbana per il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa. L’autore è Simone di Renzo e il titolo è “Comunità vs. Marginalità”.
Alcune riflessioni tra periferie, ghetti e community organizing.
AA 2017/2018.
Community Organizing. Cos’è e come funziona (Report)
Tesi-Simone-Di-Renzo (completa)
Community Organizing (Download delle slide della tesi)
A cura di Simone Di Renzo, Assistente Sociale Specialista
Questo vuole essere una specie di resoconto dell’iniziativa che ho organizzato presso l’Associazione don Nesi/Corea di Livorno, nel quale ho presentato il mio lavoro di ricerca per la tesi di laurea magistrale. L’idea è quella di avere un testo che sia fruibile sia per chi vi abbia partecipato, come strumento di spunto per ulteriori riflessioni, sia per chi non vi abbia potuto partecipare, ma che vi era comunque interessato.
Innanzitutto, dobbiamo dire che la volontà di organizzare l’incontro nasce dal fatto che avevo dedicato proprio un paragrafo della mia tesi a descrivere il lavoro che svolge l’Associazione don Nesi/Corea fin dal 2003, includendola in un excursus d’analisi sull’approccio di intervento sociale denominato community organzing o – più semplicemente – l’organizzazione di comunità.
Nella presentazione del mio lavoro sono perciò partito dal tentativo di spingermi un po’ più in là rispetto a quanto elaborato nella tesi, mantenendo comunque l’impostazione di studio, ossia quella di partire dall’analisi del fenomeno della marginalità urbana, per poi arrivare a comprendere cosa sia una comunità e come si possa pensare ad un intervento al suo interno.
Povertà, esclusione, marginalizzazione, devianza, rivendicazione, rabbia, abbandono, solitudine, droga, suicidio e isolamento, sono solo alcune infatti delle aggettivazioni con le quali si possono descrivere i contesti delle nostre periferie.
Nell’approcciarmi a un lavoro di ricerca, io poi parto sempre dall’idea del sociologo francese Henri Lefebvre, secondo cui lo scopo della sociologia dovrebbe essere quello di formulare una teoria critica della società borghese, in quanto disciplina figlia di questa società, cercandone di accentuare l’aspetto radicale dell’indagine sociologica, per recuperare quella totalità – nel suo senso hegeliano – che ci possa permettere di superare l’alienazione e la frammentazione della coscienza di classe, a favore di una reale emancipazione.
Ciò mi ha dato un incredibile spunto per tracciare una sorta di mappa della marginalità urbana, coniugando diversi studi al riguardo.
In primo luogo, sono partito dal capire cosa sia una città, aldilà della semplice organizzazione di volumi e di spazi, di gestione di pieni e di vuoti, di scelte urbanistiche e architettoniche, nell’intento quindi di comprendere cosa sia quell’insieme di relazioni, di flussi, di legami tra persone che la vivono e la attraversano, coloro che formano la cosiddetta comunità dei cittadini, quella soggettività – cosciente o no – che diventa soprattutto una comunità politica, ovvero il contesto dove uomini e donne prendono decisioni al riguardo di sé stessi e delle modalità del loro vivere insieme.
Partendo da questa definizione, potremmo pertanto dire che “la città nasce per la politica [e] la politica ha bisogno della città”1.
Questo aspetto è molto importante, perché mi ha permesso di collegare questo ragionamento ad alcune importanti riflessioni che ho scelto di sottolineare nella presentazione del mio lavoro.
Innanzitutto, una visione della “vita urbana” come emersione – continua – dell’esperienza che ne facciamo che, come direbbe l’antropologo svedese Ulf Hannerz nel suo lavoro di applicazione del metodo goffmaniano di ribalta/retroscena allo studio delle città, sostiene come ciò contribuisca a definire la nostra identità sociale.
Proprio per questo motivo mi sono riallacciato alla visione geografica elaborata da Ugo Rossi e Alberto Vanolo, i quali, guardando alla politica della città, sostengono come i meccanismi di identificazione e di riconoscimento dell’altro abbiano un potere performativo sulla nostra esperienza, condizionando i discorsi strumentali e le specifiche visioni del mondo, influenzati perciò da particolari interessi politici ed economici.
Su questo punto insiste notevolmente David Harvey, geografo e sociologo urbano marxista, il quale mostra come le classi dominanti, organizzate nello Stato e negli apparati di governo e dell’amministrazione locale, utilizzino il settore immobiliare come vero e proprio regolatore anti-ciclico del sistema capitalistico.
“Il processo di produzione dello spazio urbano implica dunque non solo la costruzione delle strutture materiali della città, bensì anche la generazione di più ampie e multidimensionali relazioni socio-spaziali”2 aggiungono poi Rossi e Vanolo.
Se guardiamo perciò ai contesti delle periferie urbane, siamo in grado di capire meglio quella specie di stigma, di immagine continuamente costruita e ri-costruita sulla base di un discrimine, di una differenza, facendo del soggetto sociale più debole, più sfruttato, più “incapace” agli occhi della classe dominante, un qualcosa di altro, da espellere, o comunque da porre ai margini della comunità.
È per questo che nella mia analisi ho scelto di interessarmi al lavoro del sociologo urbano francese Loïc Wacquant, con il suo testo “I reietti della città”, che cerca di farci comprendere come i fenomeni di ghettizzazione agiscano seguendo una precisa direzione, ossia il risultato di dimensioni economiche di sfruttamento e mantenimento di zone povere all’interno delle città, volute dalla classe dominante. La marginalizzazione avviene, perciò, sempre e comunque per via di una volontà economica e politica precisa.
Ho cercato di dimostrare quanto sto dicendo fattivamente, grazie all’utilizzo della psicogeografia, uno strumento di indagine urbana elaborato in seno all’Internazionale Situazionista, un’organizzazione nata in Francia alla fine degli anni ’50 e molto attiva nel Maggio del ’68. Per il nostro lavoro, è un metodo d’analisi perfetto, perché capace di dimostrare materialmente i ragionamenti fin qui presentati. Ricordiamo, infatti, che la psicogeografia è uno “studio degli effetti precisi dell’ambiente geografico, disposto coscientemente o meno, che agisce direttamente sul comportamento affettivo degli individui”3.
La mappa psicogeografica da me presentata nella tesi, dimostra benissimo come esista una sorta di mezzaluna rossa posta intorno al centro cittadino, e che difatti esclude le classi meno abbienti da tutti i centri di potere politico-economici della città, e da tutte le parti più tradizionalmente legate alla “bella vita” cittadina. Una sorta di vera e propria esclusione delle classi povere dal centro città, quindi, costrette a raggrupparsi in quartieri popolari a prevalente edilizia pubblica, con il risultato – spesso – della formazione di autentici ghetti.
A tal proposito, è proprio grazie al lavoro di Wacquant che comprendiamo come esistano profonde differenze tra le varie esperienze di marginalità urbana, ma anche di come esse abbiano tutte un importante dato in comune: esse formano ognuna una comunità impossibile, una situazione in cui le persone vivono in costante divisione contro sé stessi, senza riuscire a riconoscere, invece, la natura collettiva della propria situazione.
Ma è proprio partendo da questa dimensione comunitaria che possiamo tentare di intervenire.
L’approccio di community organizing, a questo punto, è a dir poco dirompente in questo ragionamento.
Partendo dal fatto che il mio corso di studi mi preparava alla professione dell’Assistente Sociale, avevo in mente di essere anche propositivo nella tesi al riguardo della problematica studiata, ed è per questo motivo che ho scelto di studiare il community organizing come approccio di lavoro dei servizi sociali, molto diffuso nei paesi anglosassoni, ma formalmente poco nel nostro paese.
Dico formalmente, perché l’idea della tesi è che sia l’esatto opposto.
In forme assolutamente spurie – e per lo più inconsapevoli – una molteplicità di attori agisce nei propri territori in base a questa tecnica di lavoro. Il mio intento era di portare alla luce questa tipologia di intervento e cercare di capire come possa essere utile e di efficace utilizzo, e come possano essere valorizzate queste esperienze definite spurie.
Sono partito però anche in questo caso dal definire una comunità, ossia quella sommatoria di legami e relazioni significative tra persone; di affiliazione spontanea, data dalla prossimità fisica, culturale e sociale; di affettività, perché – come dicevamo – si compone di legami e relazioni significative, informali e dirette, autentiche e vere; e di come assume una valenza politica, in quanto viene vista come la forma di convivenza migliore e meno alienante rispetto all’individualismo dei tempi contemporanei, capace perciò di poter migliorare la qualità della vita umana.
Ne ho voluto capire anche il senso, perché se devo andare ad agire in un determinato contesto, ho bisogno di tutti i dati possibili per agire al meglio. E allora, il modello di valutazione multidimensionale creato dagli psicologi americani McMillan e Chavis, è risultato fondamentale nell’indagare il sentimento di appartenenza e di connessione personale, per comprendere come l’individuo possa così identificare distintamente dove comincia e dove finisce la comunità e chi ne fa parte; l’influenzamento e il potere, perché gli individui hanno bisogno di poter provare un minimo di controllo su ciò che stanno facendo, una sorta quindi di “autonomia decisionale” per poter esercitare il proprio “potere”; l’integrazione e la soddisfazione dei bisogni, ovvero il motivo per cui si sta dentro una comunità; e la connessione emotiva condivisa, che rappresenta quel legame affettivo che accomuna i membri tra loro, l’autentica qualità della comunità.
A questo punto ho enucleato i punti principali di intervento messi in luce dal massimo esponente del community organizing, Saul Alinsky, una sorta di Lenin americano, una persona che ha dedicato la sua intera vita alle battaglie portate avanti dagli “ultimi”, da tutte quelle parti di società più deboli e più esposte al ricatto e allo sfruttamento capitalistico, trasmettendo loro la voglia di riprendersi i propri diritti.
Alinsky, descrive il lavoro di organizing come composto da alcuni fondamentali punti: innanzitutto, è importante che l’intervento sia circoscritto fisicamente – come il quartiere, ad esempio – perché sono fondamentali i legami naturali di unità e identificazione; serve poi una leadership capace e riconosciuta da tutta la comunità e un lavoro inventivo, militante e costante, che non duri più di un tot di tempo (generalmente 3 anni), con un’ampia chiarezza in merito a ideali, risultati sperati e obiettivi desiderati.
L’organizer è perciò una persona con una specifica formazione; attenta e curiosa, pronta all’ascolto, che sente fortemente il suo mandato; una persona ampiamente organizzativa e pragmatica, capace di essere razionale nell’irrazionalità più totale. Deve perciò possedere un carisma forte e deve essere capace di mettere in grado le persone, i gruppi o le comunità, di accrescere la propria capacità di controllare il proprio destino, senza diventarne lui stesso il leader. Al contrario, questo dovrà essere trovato nella comunità.
Come dicevo prima, nella tesi mi sono anche impegnato a presentare degli esempi di lavoro già in atto, delle realtà che seguono già questo metodo di lavoro, spesso in maniera assolutamente inconsapevole.
Ho diviso ciò che ho indagato in due grossi gruppi: da un lato quelli più propriamente prossimi all’esperienza diretta di community organizing come intervento sociale, e dall’altro esperienze decisamente più spurie e inconsapevoli di poter essere raggruppate in questa tipologia d’intervento, e più descrivibili come esperienze di azione politica.
Nel primo gruppo ho pertanto inserito associazioni come la “BuonAbitare” fondata dallo psicologo di comunità Raffello Martini, che da decenni si occupa dell’argomento, o come la “Associazione don Nesi/Corea” che, nel quartiere “Corea” di Livorno appunto, opera un importante lavoro di presidio del territorio, con una matrice totalmente laica a dispetto del nome, e con risultati realmente tangibili.
Nel secondo, al contrario, ho inserito le esperienze di grandi centri sociali occupati e autogestiti come l’Ex-OPG di Napoli o il CS Cantiere di Milano per la loro capacità di radicarsi profondamente nel territorio circostante, e il più importante – in questo senso – a Livorno, l’Ex-Caserma Occupata per via della sua particolare organizzazione interna. Questi esperimenti, insieme al Coordinamento di Piazza San Marco – Brigata Bartelloni sempre di Livorno, sono la parte più spuria, come dicevamo, ma al tempo stesso la più concreta, data la radicalità e la temporalità d’intervento di questi soggetti.
Quanto valore si potrebbe dare al lavoro di queste realtà?
È questa la domanda che come professionista dell’intervento sociale mi sono domandato.
Per questo motivo ho ribadito l’importanza dei processi partecipativi all’interno dell’elaborazione delle programmazioni dei servizi territoriali, nella fattispecie nei Piani di Zona, spesso malamente assemblati e poco utilizzati come strumenti di condivisione, indagine, valorizzazione e implementazione dei servizi.
È questo, a mio parere, l’impegno che gli attori – pubblici e privati, del terzo settore e del mondo dell’attivismo – dovrebbero prendere al fine di costruire un’autentica opportunità d’intervento ed emancipazione dai contesti della marginalità urbana.
1 Sebastiani C. (2007), La politica delle città, il Mulino, Bologna, p.17.
2 Rossi U., Vanolo A. (2010), Geografia politica urbana, Laterza, Roma-Bari, p. 150
3 “Definizioni”, Internazionale Situazionista, 1, pp.13-14, 1958.